“Non ce la farai mai. È una pazzia!”
Queste sono le ultime parole che ho scambiato con lei; l’unica persona alla quale avevo parlato del mio folle progetto. Le ho risposto con una scrollata di spalle, anche se le avrei voluto dire che se tutti coloro i quali in passato, si fossero arresi all’evidenza dei fatti e avessero abbandonato i loro folli progetti, come Colombo, i fratelli Wright, Pasteur, il mondo oggi sarebbe molto diverso. Meglio o peggio non so: solo diverso. Sono giovane e timido e quella ragazza mi metteva soggezione e così non ho replicato. Chissà dove è ora e cosa pensa di quel suo amico di un tempo, ora rinchiuso in un carcere sovietico, forse per sempre.
É trascorso quasi un anno da quando, in quel parco di Amburgo, la città dove vivevo con i miei genitori, ho preso la decisione di atterrare sulla Piazza Rossa di Mosca.
“Perché l’hai fatto?”: quante volte mi sono sentito ripetere questa domanda durante gli estenuati interrogatori del KGB.
“Volevo portare un messaggio di pace: Est e Ovest, Russi e Americani devono deporre le armi e mettere fine alla Guerra Fredda. Un gesto simbolico. Un volo come un ponte ideale. Per dire ai leader dei due blocchi che la gente, dalle due parti della cortina di ferro, voleva solo vivere in pace” gli ho risposto ma loro non mi hanno mai creduto.
Tra i miei aguzzini c’era un tizio grosso in divisa, sempre sudato, dalle mani enormi, che ogni volta che rispondevo, mi riproponeva la medesima domanda con voce cavernosa, sottolineandola con uno schiaffone a palmo aperto: “Perché l’hai fatto?”, pam!
Ma credo comunque che anche se avessi fornito loro una qualsiasi altra giustificazione alla mia impresa, sarei comunque qui, in questa cella, non più in isolamento, come nel carcere di Lefortovo, in attesa di conoscere il mio destino.
Non rimpiango nulla, je ne regrette rien.
È stata un’avventura da giovane incosciente? Forse, ma insisto: a volte anche l’incoscienza giovanile è parte del mondo. Un volo segnato dalle paure, dal terrore di aver sbagliato e che fosse troppo tardi per tornare indietro? Sì. Eppure, solo ora me ne rendo conto, è stato è stato giusto vivere, volando, il mio sogno.
I miei legali sostengono che rischio fino a cinque anni di reclusione, anche se la mia impresa aviatoria ha scosso alle fondamenta la granitica certezza delle gerarchie del PCUS dell’inviolabilità del suolo russo. Tutti si aspettano che rotolino teste, tra i vertici del partito e dell’esercito a causa mia. È da questo potrei trarne vantaggio, perché qualcuno, tra i membri dell’esecutivo potrebbe approfittare della situazione per fare un ripulisti e mitigare la mia pena, concedendomi la grazia. Così hanno mi hanno confidato gli avvocati. Gioca a mio favore poi l’età: diciannove anni.
Ho un compagno di cella simpatico, che parla un po’ d’inglese. Non mi ha detto perché l’hanno incarcerato e ho il sospetto che lo abbia infiltrato il KGB per estorcermi notizie. Dice che era anche lui sulla Piazza Rossa in mezzo alla folla, a caccia di turisti, quando sono atterrato. Di quei momenti ho ricordi molto nitidi, anche se ero molto concentrato sui comandi.
Rammento che dopo il lungo volo da Helsinki, finalmente ho visto comparire davanti a me Mosca con la sua immensa periferia, i viali del centro città e i mastodontici edifici, su cui grava una cappa di umidità. La visibilità era eccellente.
Gliel’avevo fatta; ero ancora vivo e vegeto. Grido di felicità.
Punto sull’aeroporto internazionale Šeremet’evo e anche lì, per i venti minuti che impiego a sorvolarlo, nessuno ha fatto caso a me. Dopo quasi sette ore di volo, scorgo, di là dal parabrezza il centro della capitale dell’Unione Sovietica. Avevo come punti di riferimento, San Basilio e l’Hotel Rossiya: quello che cercavo però era la piazza Rossa. Sono sceso a spirale, riducendo i giri del motore per prepararmi all’atterraggio.
Il mio aereo – beh non proprio mio, visto che appartiene all’Aeroclub dell’aeroporto di Amburgo e dovrò in qualche modo restituirglielo, integro – il Cessna 172 Skyhawk (Falco del cielo), è quello che si dice “un mulo dell’aria”. Non si può consideralo un bell’aereo, ma non è nemmeno brutto: ad ala alta, è lungo poco più di otto metri, con un’apertura alare di undici metri e un’altezza di quasi tre. Pesa sette quintali, meno di una station wagon, e può imbarcare tre passeggeri e il pilota. Il carrello, fisso, è triciclo; ha un solo motore che gli consente di raggiungere i 228 chilometri orari.
La piazza m’incute terrore e timore. Dall’alto mi è sembrata molto più piccola di quanto la immaginassi. Ma per atterrare al mio Cessna bastano duecento metri: ho tentato tre volte, e per ben tre volte ho ripreso quota; la folla rincorreva curiosa il mio piccolo aereo, sembrava uno di quegli stralunati film di Fellini. Ero terrorizzato dall’idea di ferire o uccidere qualcuno, ma alla fine ho visto il Bol’shoj Kamennyj Most, il grande ponte a sei corsie, e così decido di atterrare là.
Quante volte ho sfogliato i dépliant che, mi sono procurato in quella agenzia di viaggi vicino a scuola, dove attraverso le immagini a colori dei monumenti moscoviti ho cercato di memorizzare i luoghi della città dove preventivavo di atterrare. Ma la realtà e ben diversa: di questo mi sono reso conto sorvolando il centro di Mosca. Così ho puntato la prua del Cessna verso il grande ponte che scavalca la Moscowa.
Rullando, sono arrivato fino alla fine della Piazza, tra la cattedrale, il monumento a Minin e Pozharskij, la spianata che sale verso l’ingresso della torre Spasskaja. Spento il motore, sono restato per un lungo, eterno, quarto d’ora, chiuso in cabina, senza bene saper cosa fare, un po’ stordito ma inebriato.
Non sapevo ancora che era iniziata la mia ultima ora di libertà prima dell’arrivo della polizia.
La gente accorreva da tutte le parti per cercare di capire chi fossi, e da dove venissi appena atterrato nel cuore di Mosca. Facevano domande in russo che non capivo. Mi avevano scambiato per un compagno comunista della Germania dell’Est: in effetti, i colori delle insegne del mio aereo sono giallo, rosso e nero, come quelli della bandiera della Germania comunista.
Così rimango in piedi accanto all’aereo, avvolto nella mia ridicola tuta di volo rossa, incredulo e quasi impacciato davanti a siffatta accoglienza; una donna si è avvicinata e offrendomi pane e sale, una ragazza ha preso da dentro una sporta, una focaccia e me la messa tra le mani. Gli ho sorriso dicendole: “Spasibo”, una delle poche parole di russo che avevo imparato.
Poi tra la folla si è fatto largo un gruppo di soldati della milizia territoriale guidati da un ufficiale, tutti quanti scesi da una grossa vettura nera; e, come se avessero fermato per un controllo un qualsiasi automobilista, mi hanno chiesto i documenti senza contestarmi nulla, sennonché non avevo il regolare visto d’ingresso e che lì non si poteva parcheggiare; ai loro occhi che un aereo fosse atterrato sulla piazza Rossa, era un aspetto secondario di tutta quella bizzarra faccenda.
Ci hanno pensato gli uomini che sono arrivati in seguito, a bordo di una Volga, sempre nera, l’unico colore disponibile delle auto sovietiche, seguiti da un camion. I poliziotti del Comitato per la Sicurezza dello Stato avevano le idee un po’ più chiare dei loro colleghi della milizia: con modi spicci e senza troppi complimenti hanno fatto sgombrare la folla e messo delle transenne attorno al Cessna, e invitandomi a seguirli; non sapevo ancora che si trattava del KGB e che mi avrebbero rinchiuso in una cella d’isolamento e percosso. E ora eccomi qua.
L’unico rimpianto è il dolore che sto provocando ai miei genitori che in questo momento saranno molto preoccupati per la mia sorte. Spero che i funzionari dell’ambasciata tedesca li tengano informati rassicurandoli.
È l’ora del rancio e devo dire che nelle carceri russe non si mangia poi così male: il cibo è abbondante, anche se il menù è un po’ monotono. Mi ci dovrò abituare.
Il mio compagno di cella non riesce a saziarsi né del vitto né del racconto del mio volo, che gli ho già ripetuto una decina di volte: lui vuole sempre nuovi particolare e sgrana sempre gli occhi esclamando «wow», nel punto in cui gli narro dell’arrivo dei Mig. Anche se fosse una spia, questo non modificherebbe di una virgola la mia posizione, visto che il racconto è identico a quello estortomi dal KGB. Così, mentre ripone la sua scodella ricomincio da capo.
A venticinque chilometri, a ovest della mia città, Amburgo, nei pressi di Uetersen sorge l’aeroporto internazionale: il Flugplatz Uetersen, che è un grande e importante scalo dove ogni giorno atterrano e decollano centinaia di aerei. Era il 13 maggio, una mite giornata di sole, è il mio minuscolo Cessna Skyhawk bianco immatricolato D-ECJB è appena stato rifornito. Ho il brevetto da soli due anni, e ho speso tutti i miei risparmi e facendomi aiutare dai parenti. Ho anche l’abilitazione al volo strumentale e fonia in inglese, ma ho al mio attivo solo cinquanta ore di pilotaggio. Sono poco più di un novellino, ma penso di avere un buon bagaglio d’esperienza nel volo sul mare aperto.
Ho noleggiato per tre settimane il piccolo monomotore dall’Aeroclub di Uetersen, che non mi domanda dove ho intenzione di andare: avrei mentito, naturalmente.
Ho dotato il mio Cessna di serbatoi supplementari, per aumentarne l’autonomia; porto con me pochissime cose: una piccola valigia, una borsa con delle mappe, un sacco a pelo, quindici litri di olio motore e un giubbotto di salvataggio. Avevo anche un casco da motociclista per proteggermi da un eventuale atterraggio di fortuna.
Avevo passato gli ultimi mesi a pianificare il volo che avrebbe dovuto condurmi a Mosca: numero di tappe, distanze da coprire, consumi di carburante, gli aeroporti dove sostare. Dopo aver preso in considerazione diverse rotte, ho deciso di puntare, per non insospettire nessuno, verso la Gran Bretagna, in direzione opposta rispetto alla mia meta finale.
Ai controllori di volo di Uetersen, ad Amburgo, ho consegnato un piano di volo che prevedeva una rotta a Ovest verso le isole Shetland.
Il mare del Nord si spalanca dinanzi a me, freddo e inospitale. Lunghe e placide onde ne segnano la superfice, mentre sono concentrato sugli strumenti di volo e monitoro costantemente la rotta. Ho la mappa infilata in un involucro di plastica trasparente, fissata sopra alla coscia. Spira un leggero vento di prua, alternato a improvvise folate più intense che fanno sobbalzare il Cessna.
Per stemperare la tensione, ho estratto dal mio bagaglio un panino e lo addentato, mangiando svogliatamente per il groppo in gola che mi accompagnava da quando avevo lasciato Amburgo.
Dopo cinque ore di volo sul mare aperto atterro alle Shetland. Tiro un sospiro di sollievo. Fino a quel momento tutto è filato liscio.
Ho parcheggiato il Cessna e ho chiesto alla società aeroportuale di rifornirlo di carburante. La notte la passo quasi insonne: dormo poco e male e solo verso il mattino riesco a prender sonno; un sonno profondo che mi ristora. Ma sono fiducioso nel successo dell’impresa che sto per compiere.
Le isole Fær Øer mi appaiono simili ad alghe verdi che paiono galleggiare sul mare. Vagar è l’unico aeroporto di queste sperdute e rocciose isole, che appartengono al regno di Danimarca. Ci atterro, con qualche difficoltà il giorno dopo il mio arrivo alle Shetland. Il controllore di volo della torre di Vagar mi aveva avvertito della presenza di un banco di nubi basse sulla zona dell’aeroporto e di probabili piogge in arrivo. Comunque appoggio le ruote sulla pista senza difficoltà.
Poi è la volta dell’Islanda, dove atterro all’aeroporto Keflavik di Reykjavik, il 15 maggio. Nella capitale islandese mi sono fermato una settimana. Così ho colto l’occasione di visitare la Hofdi House, la villa bianca che fu il luogo del vertice Reagan-Gorbaciov. Mi sono sentito rincuorato, anche se edificio era chiuso a chiave e non si poteva visitare, sentivo di essere entrato in contatto con lo spirito del luogo. Ero così emotivamente coinvolto allora ed ero così deluso dal fallimento del colloquio. Così mi ha dato la motivazione per continuare.
Come dicevo dopo sette giorni riparto: direzione, la penisola scandinava. Ancora una sacco di mare da sorvolare: mi sono sentito un po’ come Lindbergh. Atterro a Helsinki: uno stretto braccio di mare separa la piccola capitale della Finlandia dalle coste baltiche dell’Estonia. Sono determinato a portare a termine quella che considero una vera e propria missione di pace, ma sono tormentato dai dubbi che scaccio concentrandosi sugli aspetti pratici e tecnici del volo illegale che sto per compiere. Sono consapevole di rischiare la vita: quattro anni fa un Sukhoi S-15TM dell’aviazione sovietica, se ricordi, ha intercettato, a Ovest dell’isola di Sachalin, e abbattuto un Jumbo jet delle linee aeree coreane, decollato da New York e diretto a Seul, colpevole di aver sorvolato senza autorizzazione il territorio dell’URSS. So che voi sovietici non scherzate e non tollerate gesti avventati: se non hanno avuto scrupoli a uccidere i 269 passeggeri del volo KAL 007, i piloti delle Voenno-vozdusnye ily (Flotta aerea rossa dei lavoratori e dei contadini) non avranno certo rimorsi di coscienza nel mitragliare un piccolo aereo che ha osato violare i confini della vostra grande nazione socialista; hanno la licenza di uccidere.
Dopo tre giorni consegno alle autorità aeroportuali di Helsinki un piano di volo farlocco, monto di nuovo sul mio Cessna Skyhawk e metto la prua dell’aereo verso Ovest, come se volessi tornare indietro verso la Svezia. Volo a circa seicento metri di quota. Poi, una volta raggiunto il mare aperto, cambio improvvisamente rotta.
Davanti a me vedo le coste dell’Estonia; inizia il silenzio radio: spengo il transponder; è un dispositivo che, se in funzione, rende visibile gli aerei ai radar. Da questo momento non esisto più per nessuno: io e il mio Cessna siamo soli nel cielo e tutto può accadere. Mi separano da Mosca, la mia ultima meta, cinque, lunghe, ore di volo piene d’incognite alla mercé dell’aviazione e della contraerea sovietica.
Mi sentii dentro un misto di tensione lacerante e di sollievo. Ero felice: volavo verso la mèta. Ma a ogni minuto che passava, sapevo che era impossibile ripensarci, tornare indietro.
Sono da poco passate le due del 28 maggio e mio il piccolo monoplano bianco compare sui vostri radar. Ho saputo poi, qualche mese fa da un resoconto dettagliato che mi hanno fatto i miei legali che. poco dopo il mio avvistamento, il telefono di Sergej Leonidovič Sokolov, ministro della difesa dell’Unione Sovietica inizia a squillare: tutti lo cercano, esercito, aviazione, colonelli e generali, per saper cosa fare dell’intruso che non risponde alle chiamate e che sembra diretto a Mosca, senza aver chiesto nemmeno “permesso”.
In un primo tempo i piloti dei caccia, decollati per abbattermi, mi avevano scambiato per uno dei loro: il Cessna assomiglia a uno Yak 12, un piccolo monoplano civile di fabbricazione russa.
Davanti, lontano qualche chilometro, mi apparve velocissimo e luminoso un oggetto argenteo, e puntava su di me. Era un Mig della PVO, la temuta difesa aerea della vostra aeronautica. Eccolo, fu il mio primo incontro con i vostri. Un colpo al cuore.
Fu duro tenere i nervi sotto controllo. Furono pochi minuti ma tremendi.
Il Mig mi raggiunse, virò strettissimo, mi si mise dietro, poi mi affiancò, le sgargianti stelle rosse dipinte sulla fusoliera e sulle ali. Era molto più veloce di me. Indovinai appena gli occhi del pilota sotto il casco. Sembrava fissarmi. Ho la presunzione di credere che mi stimasse per il mio coraggio. Per abbattermi non avrebbe avuto bisogno nemmeno di sprecare un missile aria-aria: gli sarebbe bastato mettersi davanti al muso del mio Cessna e arrostirmi con il postbruciatore.
Non fece niente di tutto ciò, non sarei qui a raccontare del mio volo: il Mig mi seguì per un po’, poi accelerò ancora e sparì nel nulla. Pochi minuti che mi sembrarono eterni. E restai in preda a nuovi sentimenti misti. Sollievo, perché non aveva sparato. Dubbio e angoscia, per la certezza che sapevano che ero in volo sul vostro territorio.
Mi tremavano le mani e grosse gocce di sudore scendevano lungo il volto che mi asciugavo continuamente passandogli sopra il dorso della mano: scrutavo con angoscia il cielo. Ogni tanto inclinavo leggermente le ali del Cessna per avere più visibilità. Non potevo sapere che i jet con la stella rossa mi avevano appena graziato.
I vostri Mig stavano per aprire il fuoco quando dal comando fu ordinato loro di aspettare, e così se ne sono andati. Mi piacerebbe incontrare il pilota al quale, in fondo, devo la vita. In quel momento sono in volo sopra Staraja Russa, una piccola e antica città della Russia europea occidentale, edificata sulla sponda sinistra del fiume Polist’, dove la famiglia Dostoevskij passava l’estate.
Ho proseguito indisturbato il mio volo a bassa quota. Sotto le ali del Cessna scorrevano i campi coltivati a segale, patate e lino e ampie zone paludose, volavo in mezzo alle nuvole, e vedevo solo scorci di quel paesaggio così mutevole. Non sapevo che ero arrivato fino a quel punto perché la difesa aerea era in preda al caos: aveva perso i contatti con me rintracciandomi più volte; non sapevano se identificarmi come amico o nemico e, non ci crederai, mi hanno scambiato persino per un elicottero del soccorso. Finalmente ho emergere sul filo dell’orizzonte Mosca: ho urlato di gioia.
“Cosa dici, i giudici saranno clementi con me?”
“Da.”
§§§ in esclusiva per “Voci di hangar” §§§
# proprietà letteraria riservata #
 E’ la prima volta che ci troviamo in imbarazzo di fronte alla pubblicazione della biografia di un autore/autrice ospite del nostro hangar … non fosse altro per la tenerissima età, per la freschezza e la semplicità che Emma ha infuso nella stesura della manciata di parole necessarie per definirla. Per farci comprendere la sua personalità o i suoi lineamenti.
E’ la prima volta che ci troviamo in imbarazzo di fronte alla pubblicazione della biografia di un autore/autrice ospite del nostro hangar … non fosse altro per la tenerissima età, per la freschezza e la semplicità che Emma ha infuso nella stesura della manciata di parole necessarie per definirla. Per farci comprendere la sua personalità o i suoi lineamenti. 





 Va bene, Iannaccone, vedo che è preparata … che ricordi hai del tuo lavoro di prof? E non mi dire: tutti incubi! Pensa gli studenti!
Va bene, Iannaccone, vedo che è preparata … che ricordi hai del tuo lavoro di prof? E non mi dire: tutti incubi! Pensa gli studenti!

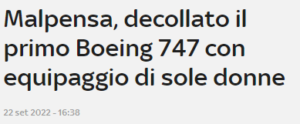



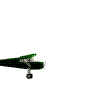 Uno dei cantanti partecipanti della 38° edizione del Festival della canzone italiana di San Remo fu Rosalino Cellamare con la canzone “Il mondo avrà una grande anima”.
Uno dei cantanti partecipanti della 38° edizione del Festival della canzone italiana di San Remo fu Rosalino Cellamare con la canzone “Il mondo avrà una grande anima”.



