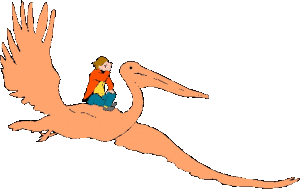Da bambino non ero come gli altri bambini che trascorrevano i giorni dietro la gonna della madre e mangiavano pane bagnato con lo zucchero. Io mi allontanavo sempre da casa, andavo per vie sconosciute sicuro di me e della via di ritorno sui miei passi.
C’era un posto dove potevo sdraiarmi indisturbato e guardare il cielo, era un campo di papaveri così alti e così tanti che da lontano apparivano ai miei occhi come un immenso tappeto rosso.
Ogni volta prendevo la rincorsa, convinto infatti di sprofondare dolcemente, invece non facevo altro che dividere in due la schiera di papaveri con il mio minuto corpo. Ma era in quel momento che trovavo il mio mondo, laddove nessuno avrebbe osato mai cercarmi, laddove nessuno avrebbe mai rubato i miei sogni.
Ad occhi in su e, con uno stelo di papavero in bocca, seguivo il volo delle rondini, cercavo di immaginare l’emozione che loro potevano provare da quell’altura vertiginosa, a quanto minuscolo poteva apparire quel campo da lassù.
Mi addormentavo quasi sempre, ed ogni volta era ora di cena quando rientravo a casa. Mio padre non alzava mai gli occhi dal piatto, mentre mia madre sbraitava davanti ai fornelli con la pentola della minestra sollevata, a gas spento, senza decidersi di portarla a tavola.
– Niente, non è rimasto niente per te. I tuoi fratelli hanno cenato un’ora fa, ed io e tuo padre ti abbiamo atteso invano. Ecco mangia quel che è rimasto poi vai a letto-.
Non avevo fame, ero sazio d’aria, non avevo sonno perché avevo già dormito abbastanza.
– Diventerai un cardellino se non mangi.
– Meglio, così finalmente potrò volare anch’io.
Era sempre a questa mia risposta che mio padre prendeva parola, ma non avevo il tempo di mettere le ali che già me le strappava.
– In gabbia ti metteremo se diventerai un cardellino, così finalmente smetterai di vagabondare.
Di notte, seduto in bilico sulla finestra, rimanevo incantato a scrutare le miriadi di lucciole. Ogni cosa volava attorno a me, o forse ero io a vedere così, ma la cosa straordinaria era aver scoperto che potevo mettere le ali alla mia fantasia, ed anche il monte più alto potevo raggiungerlo con il mio pensiero.
Di domenica, la sveglia suonava alle 7 in punto. I nonni abitavano in campagna e per arrivarci impiegavamo circa un’ora. Era sacra la domenica a casa nostra, la famiglia doveva riunirsi a qualsiasi costo.
Mio padre era il primo ad attendere sulla porta, giocherellava con l’orologio che portava al polso. La mamma, ansiosa e sudata, dava l’ultimo ritocco ai nostri vestiti, a chi metteva a posto la camicia, a chi allacciava le scarpe, e a me, a me toccava sempre stringere la cintura ed aggiungere un buchino in più talmente ero dimagrito, ma diventare un cardellino e farmi spuntare le ali, oramai era il mio unico scopo di vita.
Arrivati dai nonni, il tempo di un abbraccio e sbirciavo la stradina che portava nel bosco, non vedevo l’ora di scappare, sentirmi libero, tirare fuori dai calzoni la camicia, buttare in aria la cintura, e quando ognuno era intento alle sue cose, cercare il modo per distogliere anche i miei fratelli da me. Ero sempre il primo ad inventare un gioco da condividere con i miei cugini e sempre il primo a dissolvermi senza lasciare traccia. Non dimenticherò mai quel giorno.
Era una domenica del 1967. Mi allontanai forse troppo dall’abitazione dei nonni, tanto da dimenticare nella frenesia di libertà il sentiero di casa. Avevo notato da lontano un albero di pino altissimo, come ipnotizzato divenne il mio punto di riferimento. Era li che dovevo andare quel giorno.
Mi arrampicai come una scimmia, senza mai guardare in basso. Ero convinto che una volta in alto avrei provato l’ebbrezza di un uccello in volo pur non vibrandomi nell’aria. Dio! Era bellissimo. La grande distesa degli alberi di ulivo sembrava disegnata a matita da una linea obliqua. Le querce erano come tanti gomitoli di lana accostati e mischiati di verde chiaro e verde scuro.
Quando scorsi il mare credetti di morire, appariva come un filo sottile, ora si allargava appena, ora si assottigliava, azzurro, ma diverso dal cielo, quel cielo allora misterioso e da esplorare a tutti i costi.
I nonni, genitori e fratelli, urlavano all’inverosimile, le loro voci mi arrivavano triplicate come un eco da tutte le parti, provai a rispondere alle loro urla, ma il rombo di un aereo squarciò la magia che si era venuta a creare. Rimasi senza fiato dalla paura, ma fui come illuminato da qualcosa.
Le mani piene di bolle stringevano il ruvido tronco. Non riuscivo più a scendere. Piansi chiedendo aiuto.
I miei, come spinti da un fiuto segugio, mi ritrovarono.
Li vedevo come dei fiammiferi con la testa dipinta di nero, tra di loro una voce mi arrivava fino agli orecchi, penetrava i timpani, mi rafforzava.
– Il mio bambino. Il mio cardellino, fate qualcosa per il mio bambino.
Povera mamma, quanto dolore le avevo recato quel giorno.
Misero in subbuglio un intero paese.
C’era un bambino incollato ad un albero che non sapeva scendere a terra, ne tanto meno volare.
Di voce in voce, i fiammiferi divennero tanti e, se soltanto uno avesse deciso di accostarsi all’altro per fare qualcosa, sarebbe accaduto il peggio. Ognuno rimase al loro posto, statico ed in silenzio.
Dopo ore interminabili qualcuno gridò: – Buttati adesso,lasciati andare, non ti farai del male.
Provai a guardare giù. Non avrei mai immaginato di poter salire così in alto con la sola forza delle mie braccia.
Un lenzuolo, un cerchio bianco come la neve, una piccola piazza senza giostre, non so cosa era stato per me in quel momento il cerchio della mia salvezza, ma seguii la voce, mi lasciai andare.
Scendevo in picchiata ad una velocità folle, ma non dimenticherò l’ebbrezza di quei momenti.
Atterrai sul bianco giaciglio. Ero a terra, confuso, spogliato dai miei vestiti. I fiammiferi erano uomini curiosi, spaventati. Riconobbi appena i miei genitori tra quei volti sconosciuti.
Mio padre, chino su di me, mi sollevò lentamente, disse: – Visto Che un uomo non può volare? Ti saresti disintegrato come un frutto marcio se soltanto avessi tentato di volare.
Non ascoltavo, non volevo ascoltare, avevo ancora il rombo dell’aereo dentro la mia testa, non andava via.
Abbracciando mia madre dissi: – Non diventerò mai un cardellino mamma, ma un pilota sì. Ora lo so.
Presi il brevetto di pilota nel 1981, da allora stringo ogni mattina la cintura dei pantaloni sulla bianca divisa dove spiccano ali stampate.
Mia madre a sera mi attende con l’eterna minestra che riscalda cento volta prima che io arrivi. Il posto di mio padre è vuoto.
So che adesso mi avrebbe atteso per cenare. So che adesso avrebbe distrutto ogni gabbia pur di farmi volare.
Sarebbe stato fiero di me.
# proprietà letteraria riservata #
Maria Morabito |